HEDDA GABLER
di
Henrik Ibsen
6 / 11 dicembre 2011
Teatro Spazio Uno – Roma

Un immaginario rapporto della polizia, stilato poche ore dopo la fine della vicenda raccontata in “Hedda Gabler”, suonerebbe pressappoco così: “La signora Tesman è stata ritrovata riversa sul pavimento, davanti al pianoforte. La pistola che ne ha causato il decesso era accanto alla mano destra. Dalla posizione del corpo si può presumere che la signora fosse seduta al pianoforte fino a pochi istanti prima della morte. Non si conoscono ragioni che possano aver spinto la signora al suicidio. Era ritornata due giorni prima dal viaggio di nozze. Aspettava un bambino.”
Ibsen ripercorre i due giorni precedenti a questo gesto inspiegabile. Cosa manca a Hedda? Ha tutto quello che può desiderare: bellezza, ricchezza, un marito, una casa lussuosa. Cosa le manca, dunque? Nulla, tranne l’essenziale.
(r. t.)
ne hanno scritto…
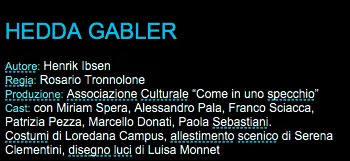

recensione di Alessandro Paesano
Fra tutti i personaggi femminili del teatro moderno quello di Hedda Gabler è forse il più frainteso, mal giudicato, vittima, anche nella sua fortuna critica, della stessa concezione della donna che Ibsen, prima ancora che denunciare, semplicemente indica nella sua pièce. Hedda è vista come donna doppia, manipolatrice, aristocratica insofferente della condizione borghese nella quale si viene suo malgrado a trovare, calcolatrice, incapace di adattarsi, di accontentarsi, disonesta, tutti pregiudizi che nascono dal maschilismo con cui viene percepita e giudicata. A ben vedere Hedda mette in luce con la sua esistenza i limiti patriarcali imposti alla donna che, per potersi esprimere, non può prescindere dall’uomo. Hedda non può prescindere dal padre, che l’ha cresciuta coltivandole il gusto per i cavalli (la cui valenza va ben al di là dell’estrazione di classe) e per le armi (che non si addicono a una donna, tant’è che lo sparo finale invece di denunciarne subito il suicido, viene accolto dal marito come una delle sue stravaganze ora ricomincia a giocare con quegli arnesi). Un padre dal quale può sottrarsi solo legandosi a un altro uomo, come quelli che ha frequentato da ragazza (cioè da donna non sposata) gli unici in grado di raccontarle una vita che a lei, in quanto donna, è preclusa, non solo il libertinaggio amorale di Ejlert Lõvborg (al quale chiede, ottenendoli, i più inconfessabili dettagli) ma anche la mera affinità intellettuale (le sottili allusioni ironiche con il consigliere Brack). Tutto si addice poco a una donna, la cui unica funzione è quella di generare la vita (non si dimentichi che Hedda è incinta) o essere musa ispiratrice per l’intelletto maschile (come fa Thea Elvsted con Ejlert Lõvborg, unica sua ragione d’essere). Hedda comprende benissimo che la vita che può avere una donna, non importa il suo rango o la sua intelligenza, è solo una vita riflessa, imprescindibile dall’uomo, dal quale non si affranca nemmeno quando conquista la libertà sessuale nell’unico modo allora riconosciutole, quello della prostituzione (come la signorina Diana, dove Ejlert trova la morte tramite un colpo di pistola esploso non alla tempia ma verso il basso ventre) perchè l’uomo in quel caso è suo cliente. Insomma tutt’altro che femmina moderna come la definisce Silvio D’Amico con misoginia insopportabile, Hedda è una donna, frustrata, la cui immoralità (nonostante non sia disposta a tradire il marito) è dedotta dai gesti che Hedda compie (la distruzione per gelosia del manoscritto di Ejlert ispiratogli da Thea, che non a caso lo intende come un figlio) o induce gli altri a compiere (l’istigazione al suicidio purché fatto con bellezza di Ejlert al quale dona una delle sue due pistole) misoginamente considerati gesti da strega mossi da calcolo o vendetta e mai, onestamente, come segno estremo di un’insoddisfazione per la sua vita, totale e devastante. Così quando il consigliere Brack prova a ricattarla sessualmente in cambio del silenzio sulla provenienza dell’arma con cui Ejlert si è suicidato, praticamente davanti a suo marito Jõrgen, troppo preso dal tentativo di recuperare il manoscritto perduto dagli appunti che Thea ha gelosamente conservato per accorgersene, a Hedda non rimane che il sudicio. Una donna capace di tale autonomia nel comportamento e nelle decisioni che riguardano anche la vita di altre persone, di altri uomini, non può che essere percepita con un fastidio tale che pur di farne una donna satanica si arriva a considerare umili (sic!) le creature che la circondano, come fa D’Amico, oppure a ridurne spessore e valenza nella constatazione superficiale che di Hedda Ibsen non ne fa un modello (come scrive Giuseppe Lanza nel dizionario Bompiani). Nell’allestimento di Rosario Tronnolone, il primo elemento cui bisogna dare merito è proprio il risarcimento morale che il regista compie nel restituire, pur rimanendo fedelissimo al testo di Ibsen (che ha ritradotto per l’occasione) la profonda, frustata e insofferente umanità di Hedda. Miriam Spera incarna una Hedda imperturbabile solo all’apparenza, percorsa in realtà da una frenesia di vivere (per sé e non per la vita o felicità altrui), tangibile, emozionante e indimenticabile. Una Hedda ben più complessa di quella semplificata dalle coordinate del maschilismo, che Miriam Spera fa sua con una sensibilità drammaturgica e una presenza scenica sorprendenti, aggiungendo un altro personaggio splendidamente interpretato ai tanti già portati precedentemente in scena. D’altronde Tronnolone sceglie con felicissima sensibilità per il casting gli interpreti di tutti i personaggi: Paola Sebastiani è una zia Julie talmente intensa da rimanere in scena ben oltre lo spazio che Ibsen le concede; Alessandro Pala è uno Jõrgen indovinatamene svagato e naïf; Marcello Donati è un Ejlert fragile e seducente proprio come gli si confà mentre Franco Sciacca è un consigliere Brack sufficientemente profittatore e senza scrupoli, mentre Patrizia Pezza dà alla signora Elvsted tutta l’irrazionale caparbietà con cui si ama incondizionatamente. Tronnolone si permetten una sola semplificazione nel testo, l’espunzione della serva Berte che rimane nell’inizio come voce fuori scena mentre, unico vero discostamento da Ibsen, apre la pièce con Hedda già in scena, di spalle, intenta a contemplarsi in uno specchio simbolico, del quale è appesa solo la cornice della scena d’effetto di Serena Clementini, che tra chaise longue, tavoli, fiori e tende, dissemina il palco di gabbie vuote, e aperte, e di cornici prive del contenuto. Scena nella quale i costumi di Loredana Campus spiccano in tutta la loro eleganza (quelli di Hedda in primis, che Miriam Spera cambia con velocità sorprendente) e le luci (di Luisa Monnet) non si limitano a restituire con con concreta efficacia le diverse ore del giorno ma si fanno anche espressione emotiva di quanto accade sul palco mentre le musiche, tratte dalla colonna sonora de La donna della porta accanto di Truffaut, commentano con un aderenza sorprendete al testo ibseniano il portato emotivo ed esistenziale della vicenda narrata il cui non detto, vera forza del testo teatrale, è elegantemente suggerito dalla regia di Tronnolone. Un accostamento non casuale al film di Truffaut, nel quale Tronnolone vede diverse rispondenze alla Hedda di Ibsen, tanto da farne un omaggio nelle note di regia presentando la storia raccontata con lo stile del film. L’associazione culturale Come in uno specchio continua a regalarci degli allestimenti impeccabili e memorabili, la cui cura artigianale mostra come il teatro sia ancora vivo e abbia molto da dire nonostante gli sforzi di molti per farlo tacere. In scena fino a domenica 11, questa Hedda Gabler è uno spettacolo imperdibile. Da vedere. A ogni costo.
Visto il 06/12/2011 a Roma (RM) Teatro: Spazio Uno

Grazie a mio padre, ho avuto la fortuna di scoprire Ibsen all’inizio della mia adolescenza; la grande impressione riportata seguendo la naturalezza dei dialoghi che l’autore scandinavo mette in bocca ai propri personaggi, prigionieri di situazioni di cui sono in buona parte inconsapevoli (ma non per questo incolpevoli) responsabili, non mi ha più
abbandonata. Per questo, quando Ibsen viene riproposto in teatro, abituata a interpretazioni quali quelle di Anna Proclemer o Lilla Brignone, ho sempre un po’ di paura…
Quando Miriam Spera ha annunciato l’apertura della nuova stagione teatrale allo Spazio Uno con la messa in scena di “Hedda Gabler” mi ha però preso una grande curiosità. I lettori forse ricorderanno che ho già avuto occasione di presentare due volte su queste pagine il lavoro della Spera: in occasione della ripresa della “Voce umana”di Jean Cocteau, e di “Tradimenti” di Harold Pinter, ambedue occasioni felici.
Anche Hedda Gabler è stata una ottima prova, anche se a mio avviso non tutti e sei gli attori erano sintonizzati sulla stessa lunghezza d’onda. Il terzetto formato da Miriam Spera (Hedda), Franco Sciacca (Consigliere Brack) e zia Julie (Paola Sebastiani) ha dato una prova eccellente di sé, calandosi – e quindi facendo calare il pubblico – nel proprio ruolo con una naturalezza incredibile. Misurati, ironici, capaci di lasciare intuire tutto il non detto che permea la scrittura di Ibsen – per il quale la comunicazione meta-verbale è almeno altrettanto importante che quella verbale: anzi, spesso corpo e sguardo devono trasmettere esattamente il contrario di quel che le parole dicono, ma giocando in modo da lasciare il dubbio su dove effettivamente stia la verità e forse proprio qui sta la grandissima difficoltà di rendere adeguatamente il proprio personaggio.
Alessandro Pala è stato a sua volta molto convincente nel ruolo dello “specialista”, del “professore” noioso che esibisce la propria moglie e la propria devozione per lei, restando però ad un livello di reale superficialità: perché tra i due non c’è comprensione e, naturalmente, neanche complicità.
Ibsen spiega perché Hedda abbia sposato Jörgen Tesman; non spiega (perché non ce n’è bisogno) perché Tesman abbia sposato Hedda. E Alessandro Pala è bravissimo nel farci capire che il suo non è vero amore, ma solo infatuazione per la bellissima e seducente donna, che rappresenta uno status symbol,ma non è mai considerata quale “persona”, con desideri, passioni, pulsioni, segreti.
Torna Ibsen
con Miriam
Spera
alias Hedda
Gabler


In basso, Henrik IBSEN
Non c’è un solo momento in cui Tesman si preoccupi davvero di cosa pensi veramente la moglie, tematica che Ibsen aveva già affrontato e approfondito una dozzina di anni prima in “casa di bambola”.
Ma Nora e Hedda sono due donne diversissime, ovviamente: per Nora ci sarà riscatto. Per Hedda, che resta sempre e comunque la ricca e viziata figlia del Generale Gabler, e non la moglie borghese di Tesman; che ha accettato consapevolmente un gioco di ruolo calato nei pregiudizi del proprio ceto sociale; che non sa uscire da una dimensione di noia reale, ben lontana dalle aspirazioni di rottura che pure essa prova, la fine non può che essere la morte. In questo Hedda, un’eroina così diversa dall’ideale di donna dell’Ottocento, è stata una figura potente, che ha introdotto nella drammaturgia una ventata di nuovo. E Miriam Spera ne ha dato un’interpretazione eccellente, centrata, disincantata e coinvolgente.
Restano ancora due personaggi nel lavoro di Ibsen: Thea Elvsted (interpretata da Patrizia Pezza) e Ejlert Lövborg (interpretato da MarcelloDonati). Personalmente, per tutta la sera, ho avuto l’impressione che la Pezza e Donati (che in Pinter avevo apprezzato molto) appartenessero ad un
altro tipo di rappresentazione teatrale: in cui il gesto vada enfatizzato, gridato, quasi sbattuto in faccia al pubblico – ponendo una sorta di pellicola semitrasparente di distacco tra il proprio sé e quello del personaggio. Devo ammettere che mi hanno decisamente convinto molto meno: nonostante il testo di Ibsen definisca Thea “un’oca”, siamo di fronte ad uno dei paradossi ibseniani cui ci riferivamo poco fa: si tratta in realtà di una donna che è stata sia capace di aiutare Ejlert a tirare fuori il meglio di sé facendolo confluire nei suoi libri, (e ricoprirà la stessa funzione anche con Tesman, guarda caso…), sia – soprattutto – capace di decidere di abbandonare il proprio marito non amato per cercare di realizzare quello in cui crede. Si tratta quindi di un personaggio molto meno monocorde, superficiale, sciocco, di quello che ci è stato proposto. Per non parlare di Donati, il cui Ejlert in nessun momento riesce a farci pensare a quell’uomo “simile a un dio” che Hedda insegue invano da sempre E se è vero che Ibsen, ovviamente, è il primo a non pensare ad Ejlert come a un semidio, è pur vero che si tratta di un uomo tormentato, geniale, perseguitato dai propri demoni, consapevolmente incapace di essere all’altezza delle aspettative che sia Hedda, sia Thea hanno nei suoi confronti: lontano, quindi, dall’interpretazione troppo “svelata” che abbiamo visto allo Spazio Uno. Resta il finale di “Hedda Gabler” – Ibsen ha sempre avuto un autentico dono nella scelta della battuta finale dei propri lavori. “Sono cose che non si fanno” dice il Consigliere Brack che si vede sfuggire la tanto agognata preda proprio quando pensava di averla ormai intrappolata.
Il regista, Rosario Tronnolone, sceglie di non mostrarci Hedda riversa nella stanza dopo essersi uccisa (nel copione originale, dopo lo sparo, Tesman accorre nella stanza posteriore sollevando le tende e quindi lasciando intravvedere il corpo esanime della moglie). Invece, le tende restano abbassate dietro di lui, e le luci (veramente curatissime ed eleganti, per tutto lo spettacolo) restano fisse appunto su Brack, scosso ma non “toccato” davvero, sul canapè, con la sua battuta, che lo ingessa per sempre nel suo atteggiamento di innamoramento di sé (Sciacca è impareggiabile nel dargli vita).
Bella scelta.
Giusta fine per una bella serata, all’insegna del profondo rispetto dell’autore, il cui messaggio ci parla ancora, senza bisogno di adattamenti rivoluzionari.













